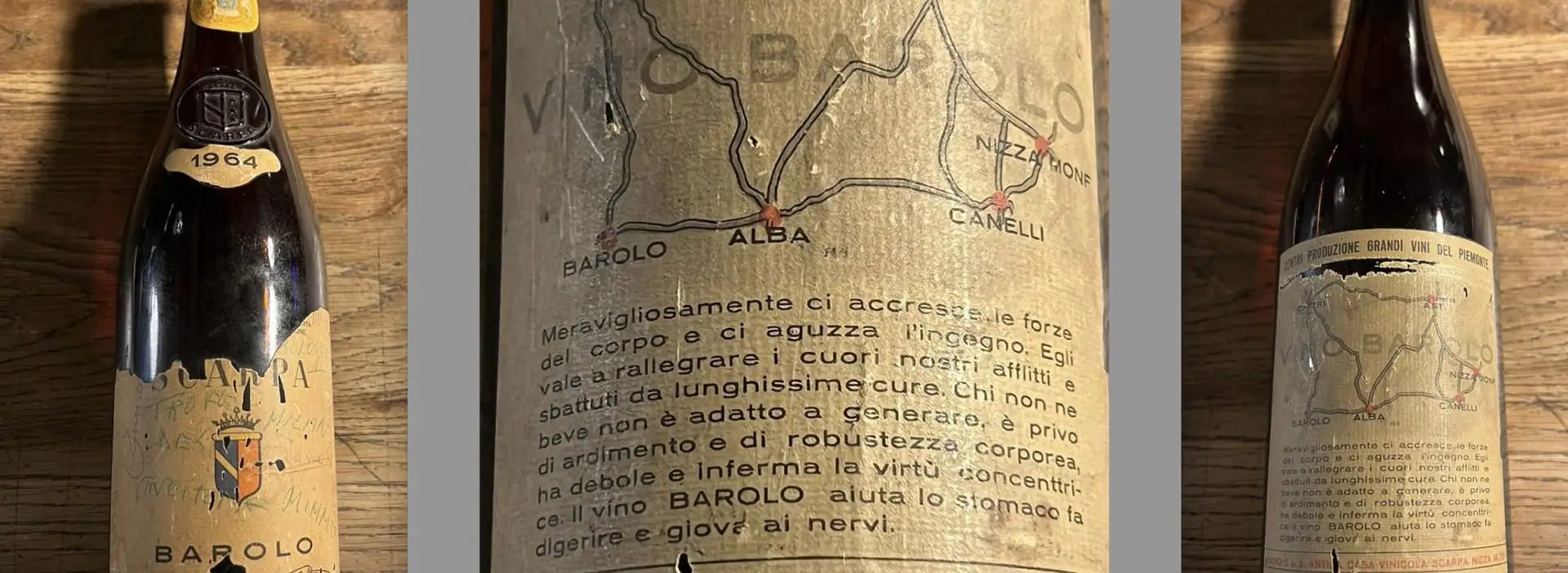- Le storie di Mimmo
Milano, sono tutto tuo
Tempo di lettura: 4 minuti e mezzo
Sotto un cielo plumbeo, denso e compatto, il treno rallentò bruscamente. Dal finestrino abbassato scorsero il cartello “Stazione Centrale”: finalmente erano a Milano.
Il breve viaggio di nozze – tre giorni trascorsi all’ombra del Colosseo e dei Fori Imperiali – per mio padre era già nell’album dei ricordi, ora avrebbe mostrato alla sua giovane sposa tutta la magnificenza della capitale lombarda. L’unico grande centro abitato del Nord Italia che potesse ambire a definirsi metropoli.
Le avrebbe fatto vedere le piazze, le chiese e i monumenti, che lui aveva già visto qualche anno prima, durante la guerra. Di quella città suadente e tentacolare ricordava soprattutto il respiro, a tratti affannato, di chi è sempre di corsa, perché deve fare, costruire, realizzare.
Lungo quel viaggio in treno che sembrava non finire mai, papà aveva raccontato a mamma quanto fosse bella Milano e di quanto fosse grande. I viali, i palazzi, il traffico, lì tutto era di una taglia in più. E poi il continuo via vai della gente, le lunghe code degli operai in tuta da lavoro che assalivano i tram.
Certo, il paesaggio era ben diverso da quello di Reggio Calabria dove erano cresciuti. Nell’aria che si respirava in Corso Buenos Aires non avrebbero mai ritrovato il profumo che hanno le alici tremolanti appena sfilate dalla rete. Cosa avrebbe detto Lina?
Dallo scambio degli anelli e quel primo bacio, a mia madre sembrava di vivere in una fiaba. Come sempre, senza darlo a vedere. C’erano prove da superare come in ogni favola che si rispetti, ma ad affrontare pericoli e ombre avrebbe avuto Mimmo al suo fianco. Non c’era da aver paura.
A Milano giunsero il sabato a mezzogiorno e la città l’avrebbero visitata un’altra volta. La sera stessa papà doveva presentarsi al lavoro, una pizzeria dalla cui entrata si scorgeva la Madonnina. Davanti al grande forno a legna, il viso arrossato dal calore e dall’ininterrotto impastare e condire una pizza dopo l’altra, papà sorrideva pensando a Lina che, come la Vincenzina di Jannacci, lo aspettava a casa.
In quelle due piccole stanze più servizi in via Dei Cinquecento, più vicino a San Donato che al Duomo di Milano, Mimmo e Lina non erano solamente sposi. L’uno per l’altra erano madre e padre, amici e complici, compagni di viaggio e di vita.
Avevano scelto di affidare il proprio destino a una città con la nebbia che saliva pesante dai fossati. Ogni giorno, papà li costeggiava in bicicletta, avanti e indietro, da casa al lavoro. Erano profughi per necessità, insieme ad altri profughi, pronti a colmare con le proprie aspirazioni lo spazio smisurato di quei viali alberati.
Terminato il turno serale, Mimmo pedalava spedito verso casa, non riuscendo mai ad arrivare prima dell’una di notte. Ben fissata sul portapacchi c’era sempre una pizza. Condividerla dopo averla riscaldata velocemente nel forno elettrico era diventato un rito, un simbolo della loro unione. In quell’impasto di acqua e farina che li nutriva ogni sera, sacrifici e aspettative erano ingredienti essenziali, quelli di un’esistenza che scorreva veloce.
Gli anni Cinquanta erano già iniziati e in tutti gli italiani vi era il desiderio di recuperare il tempo perduto durante quella guerra maledetta e fratricida. Nella capitale italiana degli affari e del commercio apparvero le prime insegne luminose. Ecco arrivata la pubblicità. Cinzano e gli elettrodomestici Candy, l’omino del lucido da scarpe della Brill e la signorina Kores che batte instancabilmente a macchina.
Il boom economico prendeva forma in Piazza Duomo, dove le luci al neon coloravano l’aria della sera riflettendosi a intermittenza sull’asfalto bagnato dalla pioggia o dal lavaggio delle strade. Da una parte la solennità del Duomo e dall’altra i simboli del consumismo ormai alle porte. Sacro e profano convivevano in pace e a braccia aperte per accogliere un futuro gravido di promesse e sicuro benessere.
Trascorsero anni duri e felici. Nonostante fosse arrivata la prima figlia, papà riusciva a risparmiare anche 20 mila lire al mese, che in breve tempo diventarono 500 mila. Si era comprato una Lambretta nuova di zecca ma ciò che aveva conquistato così faticosamente ora non gli bastava più.
Nacque la seconda figlia e alla clinica Mangiagalli, nella stessa stanza in cui era ricoverata mia madre, papà rivide una sua vecchia fiamma, Giovanna, anche lei diventata mamma in quei giorni. Si erano conosciuti dieci anni prima sui banchi di lavoro di una fabbrica di cinturini per orologi. Un giorno si erano nascosti nella cantina della fabbrica per salvarsi dal bombardamento degli americani, che a quell’epoca erano i nemici, trascorrendo più di un’ora al buio mano nella mano. In quella camera spoglia del reparto maternità, i loro sguardi si incrociarono per un attimo, lei gli sorrise e tutto finì lì. Non era più il tempo di abbandonarsi ai ricordi, ora contava solo il futuro ed era tutto da costruire.
Come nella scena finale di Miracolo a Milano, dove i senza tetto volano adoperando le scope dei netturbini, in quella grande città ognuno inseguiva il proprio sogno con la certezza di poterlo realizzare. Così un giorno mio padre decise di prendere armi e bagagli e, come San Giuseppe, portarsi dietro tutta la famiglia per trasferirsi a Bergamo, in Città Alta. Lì avrebbe iniziato una nuova avventura, un’attività tutta sua.
Davanti alla vecchia insegna che presto avrebbero sostituito, mamma e papà si guardarono negli occhi. Nello sguardo condivisero lo stesso pensiero: “Siamo sicuri? Chi ce lo ha fatto fare?”.
Capitava di rado, ma quella volta si strinsero le mani. Ora dovevano essere uniti più che mai. Mio padre abbozzò un sorriso: “Su, entriamo, cominciamo a vedere come è messo il forno”.