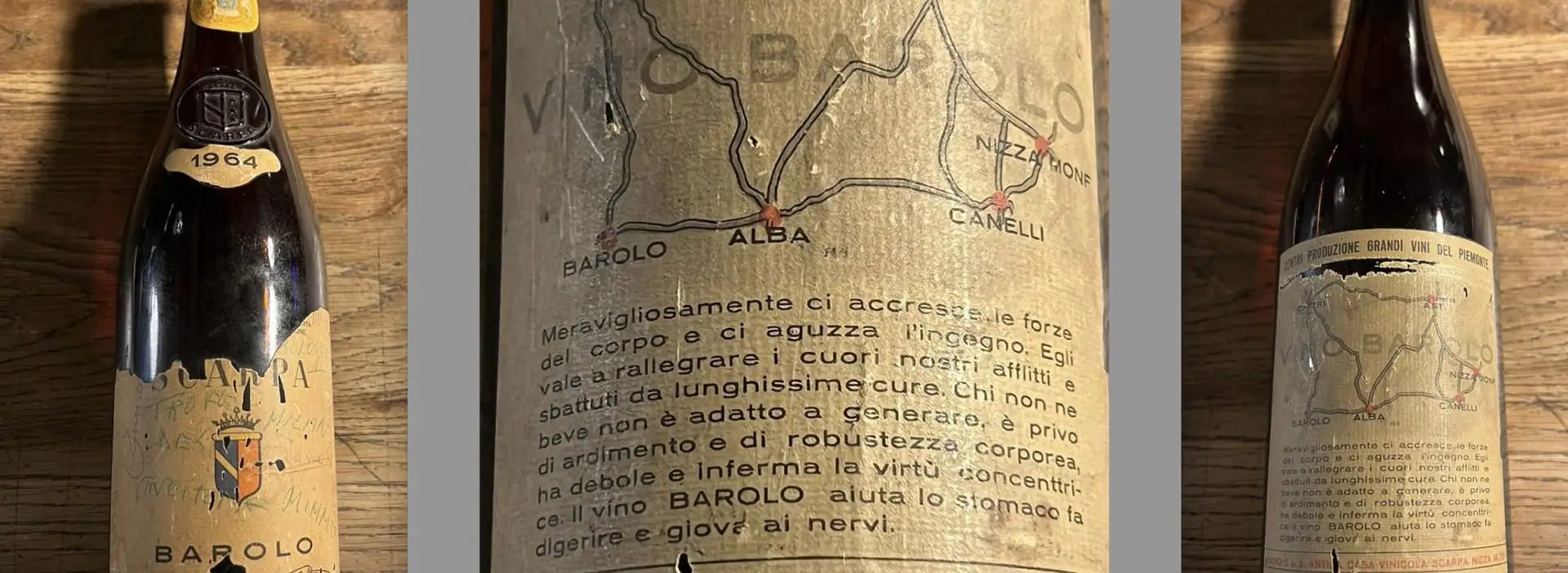- Le storie di Mimmo
I nomi americani
Tempo di lettura: 5 minuti e mezzo
Io e mio padre abbiamo sempre vissuto in controtendenza. Lui aveva lo sguardo perennemente rivolto al futuro, a un domani senza dubbio migliore dell’oggi. Io, con lo stesso sguardo indagatore, interpellavo il passato per comprendere chi ero, da dove venivo e cosa sarei diventato.
Avevamo quarant’anni di differenza. Il tempo giusto per diventare padre di un quinto figlio. Se poi esiste un tempo giusto per diventare padri e figli. Di certo, quarant’anni era un periodo sufficiente per avere idee opposte su qualsivoglia argomento. Il nostro rapporto era fondato su una controversia perenne, seppur con lo stesso fine, in un eterno fluire tra passato e futuro.
Gli uomini come mio padre avevano conosciuto l’incertezza del vivere. Per loro il concetto, oggi molto in voga, di “restanza” non esisteva. Bisognava andare, partire per conquistarsi una nuova vita. Ed erano tutti assetati di novità e progresso. A loro, ogni piccola innovazione tecnologica sembrava un dono piovuto dal cielo, da scartare con mani ferme e un sorriso sul volto. Erano uomini seri, a volte serissimi, abilissimi nel non prendersi mai sul serio.
In cantina, conservo ancora la prima impastatrice di mio padre che, a sentir lui, gli salvò la schiena. Quella spina dorsale affaticata che, fino al 1965, era costretta a piegarsi per impastare a mano.
Perché la modernità era rappresentata dal primo uomo sulla luna, come ce la raccontò Tito Stagno nella telecronaca più famosa di sempre, ma anche da un semplice elettrodomestico che ti semplificava la vita permettendoti di faticare un po’ meno.
Papà guardava estasiato gli orologi a cristalli liquidi, così pratici e moderni. Io quelli a carica manuale, con quel movimento impercettibile delle lancette a scandire l’incedere del tempo. Lui sempre sui rami a osservare il cielo da vicino, io a studiare le radici per cercare di capire come funzionano le cose.
Papà aveva una certezza su tutte, che la vita fosse semplice pur se inspiegabile. Io, di contro, avevo un’urgenza irreprimibile, quella di complicarmela, la vita, preferibilmente senza alcuna balia al fianco. Entrambi cercavamo a modo nostro il domani, ma lui sapeva bene che futuro e avvenire sono due cose differenti.
Sul cibo la faccenda si faceva molto seria e poteva assumere toni epici. Per la famiglia Amaddeo, ogni pietanza della tradizione era sacra. Tanto che la mia iniziazione ai piatti di famiglia fu molto simile a quella di un cavaliere Templare introdotto al culto del Sacro Graal.
Dopo essere stato educato alla bontà assoluta e inarrivabile della parmigiana di melanzane e delle polpette di carne, della pasta e fagioli e dello stoccafisso alla messinese – la cui preparazione inondava la casa di odori che a me sembravano sgradevoli, fin troppo decisi e pungenti – più di una volta, e l’ho già raccontato, trovai papà in cucina a spalmarsi sul pane del Philadelphia Kraft.
Condividendo lo stesso entusiasmo di Kaori, la ragazza finto giapponese della pubblicità anni Novanta, mio padre adorava quella che io ritenevo una mezza porcheria.
In realtà, questa “cream cheese” esiste da più di un secolo. Prodotta per la prima volta da un casaro newyorkese a fine Ottocento, fu chiamata Philadelphia in onore di quella che, all’epoca, era considerata la città americana da cui provenivano le più raffinate ghiottonerie di tutti gli Stati Uniti. Nel tempo, il suo successo a mio parere immotivato divenne planetario, tanto che in Spagna il termine Philadelphia è entrato nel linguaggio comune per indicare qualunque tipo di formaggio spalmabile.
Al manifestarsi del mio disappunto per quella scelta che pugnalava al cuore la tradizione culinaria di famiglia, papà replicava con uscite spiazzanti e a dir poco fantasiose, del tipo: “Mi piacciono i nomi americani”.
Mio padre era davvero imprevedibile. Qualche volta, anche simpaticamente bugiardo fino a negare l’evidenza, pronto a cambiare idea da un momento all’altro. Una peculiarità, definiamola in questo modo, che gli perdonavano tutti, compensata da un cuore generoso.
Quando arrivò il quarantesimo anniversario di matrimonio dei miei genitori, papà riuscì a sorprenderci per l’ennesima volta. Noi figli avevamo in serbo per loro un regalo coi fiocchi: un antico e pregiato letto in palissandro, con testiera intarsiata, che scovammo da un noto antiquario di Bergamo. Un’opera d’arte che papà studiò attentamente girandogli intorno con fare perplesso.
Era evidente, quel regalo non lo entusiasmava affatto. Feci un bel respiro e gli chiesi cosa non lo convincesse. Lui mi rispose senza batter ciglio: “In un letto come questo c’è morto mio nonno”.
Non passarono dieci giorni e quel letto prese altre strade, ben lontane da Città Alta. Al suo posto, nella camera dei miei genitori, comparve un letto dal design pulito ed essenziale, con mobile e comodini annessi. Il nuovo arredamento, scelto da mio padre, comprendeva anche un televisore dotato di un telecomando che, oltre a regolare il volume e cambiare i canali, permetteva alla TV di ruotare a destra e a sinistra. Vuoi mettere?
Tutto il tempo insieme, sette giorni su sette, eppure non ci siamo mai parlati a cuore aperto. La maggior parte di noi, nati negli anni Sessanta, non ha mai avuto molta confidenza con i padri. Al contrario dei ragazzi di oggi, noi comunicavamo poco con loro. Tuttavia, che fossero di approvazione o di protesta, i nostri silenzi potevano essere assordanti, grondavano significato, reclamavano indipendenza e libertà.
La realtà è che io non avevo tempo da perdere e papà non ne aveva da dare. O quanto meno io la pensavo così. Ma quanta nostalgia per quelle domande apparentemente scontate, il più delle volte intempestive o fuori tempo massimo. “Dove vai? Dove sei? Che tempo fa lì? Hai mangiato?”. Oggi, quelle frasi di sola andata mi mancano tantissimo. Mi manca lui.
Ci sono momenti, di solito in ora tarda, in cui i ricordi legati a papà fluttuano liberi e incontrollati. E vanno sempre al mese di agosto. È il mese in cui è nato e quello in cui se n’è andato. È il mese dei pochi momenti di vacanza trascorsi insieme. Il mese dei temporali che giungono all’improvviso, in cui la luce inizia ad annoiarsi di illuminare le giornate. E da molto lontano si comincia a vedere l’autunno.
Ora che siamo a novembre, come ci avvertiva il Pascoli, il sole così chiaro è solo un’illusione. La natura è muta e le sfumature cupe dell’inverno che incombe ci rammentano coloro che non ci sono più.
Con il trascorrere dei mesi e degli anni, il ricordo di mio padre si è fatto sempre più dolce. Tra me e lui ci saranno sempre quarant’anni, ma non sono più una distanza. Ora lo so. Finalmente.