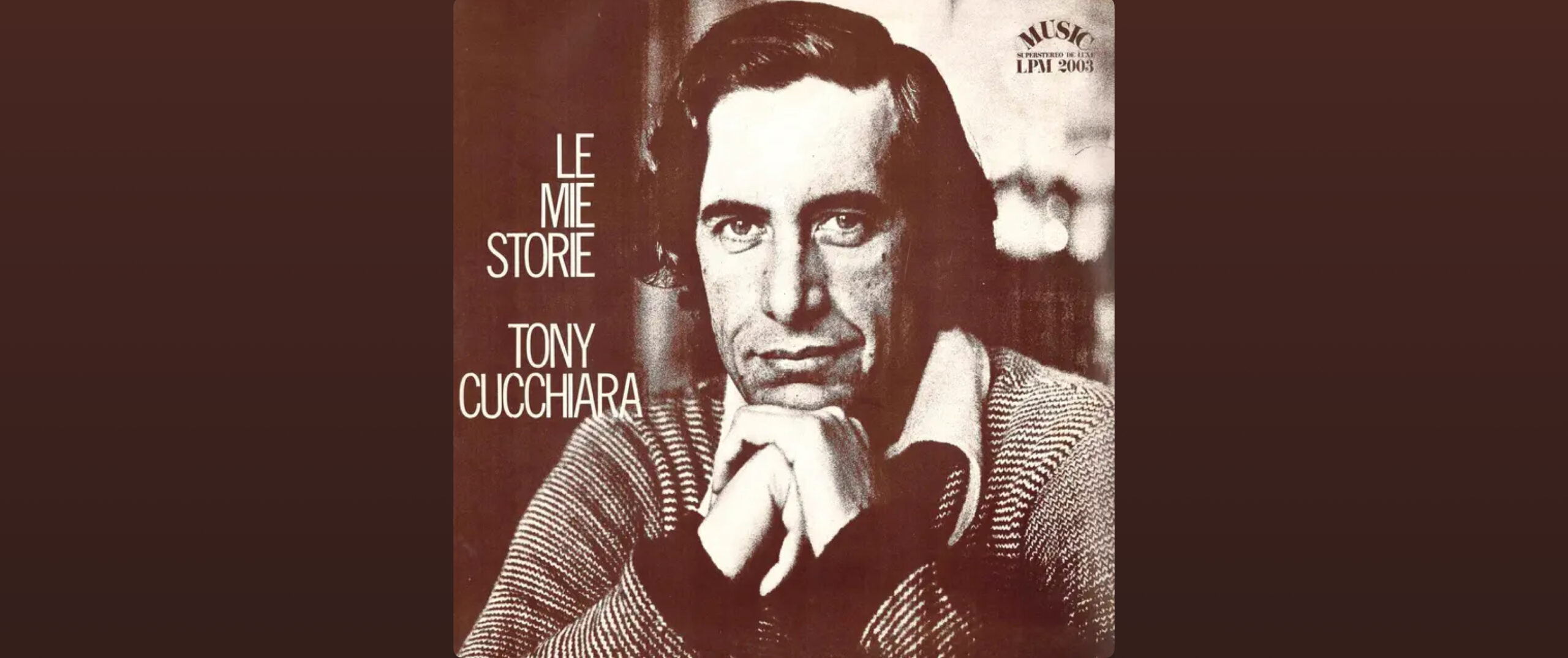- Due calci al pallone
I Mondiali d’Argentina. Parte prima
Tempo di lettura: 7 minuti
Avevo appena spento tredici candeline e l’eccitazione era a mille: mancava poco più di un mese all’inizio dei Mondiali: Argentina 78.
A quell’età non aspettavo altro che di giocare a pallone o di vedere una partita, dal vivo o in tivù. Una malattia acuta, visibilmente cronica, dalla quale, senza alcun dispiacere, non sono più guarito.
Una volta terminati i compiti e palleggiato a lungo sulla terrazza del ristorante, nel poco tempo libero che mi rimaneva studiavo meticolosamente l’almanacco del calcio. Volevo sapere tutto di tutti. Il nome, le caratteristiche tecniche e la carriera di ogni giocatore, specie di quelli poco noti. Gente che si guadagnava da vivere in provincia prendendo a calci un pallone e, qualche volta, gli avversari. Sconosciuti non sempre illustri che correvano senza sosta dove l’erba solo di rado era tagliata come si deve ma dove il fango, nelle giornate di pioggia, non mancava mai.
Troppo facile conoscere vita, morte e miracoli, di Gianni Rivera o di Edson Arantes do Nascimento, per tutti “Pelè”. Mi appassionava di più la storia di Claudio Correnti, che giocò per nove anni nel Como diventandone il capitano, o di Fausto Pezzato, attaccante della Spal che aveva affondato i tacchetti dei suoi scarpini in molti campi infuocati del Sud, da Foggia a Salerno, da Bari a Terni.
Venne giugno e, con la fine della scuola, finalmente iniziarono i Mondiali. Si giocavano in Argentina, dall’altra parte del mondo, dove la nostra Nazionale era chiamata a dimostrare, agli italiani e al mondo intero, di aver voltato pagina e di essersi ripresa dalla batosta di quattro anni prima. Quelle tre partite con Haiti, Argentina e Polonia, giocate in Germania nel 1974 avevano segnato la fine di un ciclo indimenticabile, quello dei grandi giocatori dei primi anni Settanta, come Rivera, Riva e Mazzola. Bisognava chiudere con il passato e ripartire.
Erano gli anni del “blocco juventino” sul quale Enzo Bearzot, il “Vecio”, aveva costruito l’ossatura della squadra. Zoff, Gentile, Cabrini, Scirea, Benetti (che mal sopportavo di vedere in maglia bianconera), Tardelli, Causio e Bettega erano titolari fissi di quell’Italia. Nessuno del mio Milan, tranne Aldo Maldera che ahimè finì in panchina proprio per l’esplosione del bell’Antonio. Cabrini, ovviamente.
Nello stesso periodo in cui mi innamorai follemente del pallone, cresceva in me un grande interesse per ciò che avveniva lontano dal mio Paese e dall’Europa. Altre vite, altri luoghi. Questa inclinazione, che persiste tutt’oggi, la devo a un’insegnante di italiano particolarmente illuminata che ci aveva educato alla lettura di quotidiani e periodici per responsabilizzarci, facendoci sentire parte di una coscienza civile.
Di lei, la professoressa Silvana Tacchio, che occasionalmente incontro ancora in Città Alta, ho solo bellissimi ricordi. Un’insegnante che, per far comprendere al meglio le vicissitudini di Cosimo, il protagonista del “Barone rampante” di Italo Calvino, leggeva il romanzo con i suoi studenti sugli alberi.
Fu così che mi documentai sulla situazione politica argentina e, più in generale, su quella del Sud America, un continente funestato da spietate dittature militari. Dall’Uruguay al Brasile, dal Cile all’Argentina, negli anni Sessanta e Settanta in America Latina fu un susseguirsi di colpi di stato che portarono al potere individui in divisa ossessionati dal contrastare con ogni mezzo le forze popolari.
Spesso lo sport è servito ai regimi totalitari per esaltare le presunte virtù di una razza, o di un popolo, e al tempo stesso per nascondere le infamie dei governanti. Era già accaduto alle olimpiadi di Berlino del 1936, trasformate da Hitler in un evento di propaganda nazista. Il Führer avrebbe voluto innalzare a modello la razza ariana ma fu sfacciatamente smentito dai risultati dall’afroamericano Jesse Owens che, sotto il suo sguardo, vinse quattro medaglie d’oro.
A distanza di quarantaquattro anni, il Mondiale di calcio veniva ospitato da un Paese dove la libertà di pensiero non era contemplata. Nel 1934 era toccato all’Italia fascista di Mussolini e ora era la volta dell’Argentina, governata da una spietata junta militar.
Solo due anni prima, il controllo del Paese era stato assunto da una nefasta congrega di militari guidati dal generale Jorge Rafael Videla, comandante in capo dell’esercito, di fatto il quarantaduesimo presidente del Paese sudamericano. Annunciarono l’intento di attuare un efficace “processo di riorganizzazione nazionale” che, nella realtà, si tradusse in un vero e proprio terrorismo di Stato volto a eliminare ogni forma di dissenso.
Nonostante le orribili notizie provenienti da Buenos Aires e dintorni, la FIFA sostenne pienamente la candidatura argentina, nel segno di una legittima autonomia dello sport dalla politica.
Tempo prima, in Argentina, erano stati arrestati come sospetti sovversivi i figli di un influente politico brasiliano. Joao Havelange, ex pallanuotista e ora presidente plenipotenziario della FIFA, anch’egli brasileiro, si interessò direttamente con il generale Videla per loro liberazione, che avvenne in cambio della certezza di poter ospitare il Mondiale 1978.
Anche il vicepresidente della FIFA, il tedesco Hermann Neuberger – diligente capitano della Wehrmacht durante la Seconda Guerra – dichiarò: “Non esistono premesse migliori per lo svolgimento del torneo”. La Germania, d’altronde, era partner economico dell’Argentina nell’organizzazione del Mondiale. Tra i maggiori sponsor della manifestazione c’erano Mercedes, Siemens e Telefunken.
Qualche intellettuale italiano preannunciò un Mondiale fasullo – negli stadi gioia sfrenata, fuori orrori e crudeltà – ma sui maggiori quotidiani nazionali sembrava un argomento tabù. Uno dei pochi giornalisti a prendere posizione fu Gian Paolo Ormezzano che sulle pagine di Tuttosport riferiva sgomento ai propri lettori quanto stesse avvenendo in Argentina. Ci fu anche Gianni Minà che, giunto a Buenos Aires, fece le domande sbagliate e in un attimo si ritrovò su un aereo che lo riportò a Roma.
Venni a conoscenza delle madri di Plaza de Mayo e della loro protesta. Dal 30 aprile 1977, manifestavano ogni giovedì in quella enorme piazza per sapere quale sorte fosse capitata ai loro figli e mariti, portati via da automobili nere e scomparsi nel nulla.
30mila desaparecidos e 500 bambini rapiti, secondo le madri di Plaza de Mayo, 8mila morti secondo lo stesso Videla. Queste madri che non si sarebbero mai arrese ballavano da sole per protesta. “They dance alone” cantò Sting qualche anno più tardi. Lo fece anche Francesco De Gregori in “Buenos Aires”, una sua bellissima canzone del 1979.
La volontà di denunciare il dramma che stavano vivendo gli argentini arrivò anche negli stadi. I pali delle porte dello stadio Monumental di Buenos Aires furono dipinti, alla base, con una banda nera, come fossero listati a lutto. L’idea fu di un certo Ezequiel Valentini, uno degli addetti al campo di gioco di quello stadio, con l’intento di ricordare tutti coloro che erano stati uccisi o scomparsi da quando la dittatura aveva preso il potere.
Quelle strisce nere rappresentavano un’accusa nemmeno troppo camuffata a quel regime sanguinario che, a poche centinaia di metri dal Monumental, rinchiudeva migliaia di futuri desaparecidos nella prigione infernale dell’Esma, la Scuola di Meccanica dell’Esercito.
E così, senza alcun boicottaggio, i Mondiali iniziarono come se niente fosse, senza proteste o defezioni. Il 1° giugno, alle otto di sera italiane, in Argentina erano le tre del pomeriggio, l’intero pianeta si collegò con il leggendario stadio del River Plate per assistere alla partita inaugurale tra i tedeschi, campioni in carica, e la Polonia.
Ipnotizzato dallo schermo televisivo e dalla voce cadenzata di Nando Martellini, ero seduto su una sedia della cucina irrequieto quanto basta, come al solito. Mi accorsi all’istante di quei pali anomali dipinti di nero alla base ma, fortunatamente, non fu così per la junta, che non colse quell’insolita rimostranza. Determinati a organizzare i Mondiali nel proprio Paese a qualunque costo, in realtà i militari non erano interessati al calcio e di certo non lo seguivano come me, perciò non sapevano che i pali, da regolamento, devono essere completamente bianchi. L’inganno andò a buon fine e l’identità dell’autore si venne a sapere solo molto tempo dopo.
Tutto ciò avveniva sotto gli occhi di un ospite d’onore della Manifestazione davvero d’eccezione. L’ex Segretario di Stato americano Henry Kissinger – Nobel per la pace nel 1973, al contempo fervente sostenitore di Pinochet e delle altre dittature sudamericane – dichiarava: “Questo Paese ha un grande futuro, a tutti i livelli”.
Il giorno dopo arrivò anche per la nostra Nazionale il momento di scendere in campo. Oltre quell’immagine distorta di una nazione sorridente e felice sotto la tutela rassicurante dei militari, era tempo di mettere la palla al centro. L’arbitro aveva già il fischietto in bocca. Si gioca.