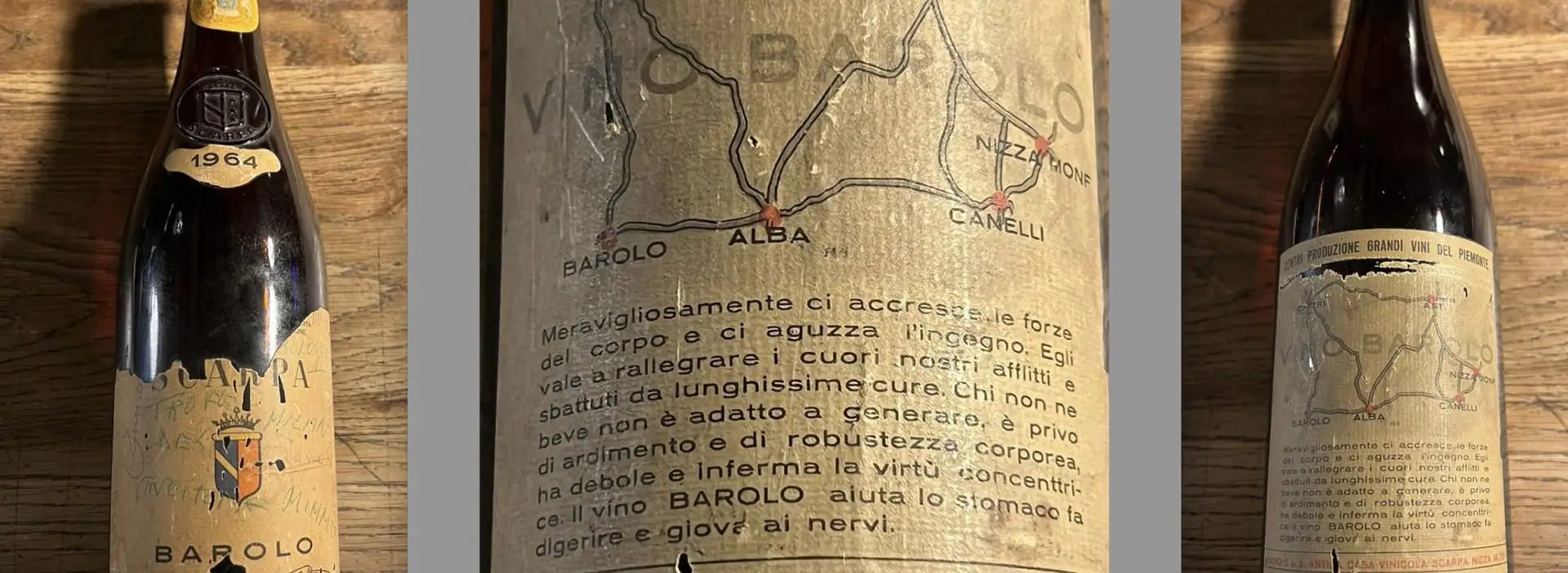- Le storie di Mimmo
Un calabrese napoletano
Tempo di lettura: 5 minuti e mezzo
Quando, nel 1956, mio padre e mia madre giunsero a Bergamo, i suoi taciturni abitanti, che fossero di quella Alta o di quella Bassa, ignoravano tutte le bontà che offriva già allora la cucina del nostro Paese. Una varietà di ingredienti, preparazioni e cotture che non ha eguali al mondo.
Eppure, era passato più di mezzo secolo da quando, alla fine dell’Ottocento, Pellegrino Artusi, letterato e gastronomo di rara competenza e sensibilità, raccolse quasi un migliaio di ricette regionali in un manuale che in breve tempo divenne un caposaldo della cultura gastronomica italiana: “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene”. Un’opera seminale, consultata ancora oggi, che pose le basi alla diffusione dei piatti più rappresentativi della nostra cucina, contribuendo a creare un linguaggio culinario comune.
Nonostante il lodevole lavoro divulgativo dell’Artusi, a metà degli anni Cinquanta i tempi non erano ancora maturi perché a Trento ci si potesse rallegrare, a tavola, con dei maccheroni alla Norma, né tantomeno sperare che a Messina qualcuno conoscesse i canederli.
Solo in una metropoli come Milano potevi trovare qualche trattoria dove apprezzare le pietanze di una cucina regionale, semplice e gustosa, che spaziava dalla Campania alla Puglia, dal Piemonte all’Emilia Romagna. Nei comuni più piccoli, come Bergamo, questo non era ancora avvenuto e, in tutta Italia, si mangiava più o meno ciò che suggeriva la cultura popolare del luogo.
Uno straordinario sogno collettivo.
Le cose stavano così, per questo poteva sembrare un azzardo aprire una pizzeria in Città Alta, pur se in un luogo frequentato, di passaggio e di passeggio, nel tratto che unisce Piazza Vecchia alla Cittadella. Anche perché, in quegli anni, si usciva poco la sera e solo nel fine settimana.
Emigrare per cercare fortuna e garantire un futuro migliore ai propri figli significava anche portarsi appresso un bagaglio, assai ricco e voluminoso, di ricordi e di emozioni legate alla terra natia ma, soprattutto, di ricette, quelle dei piatti di mamma e di nonna, della festa e di tutti i giorni.
Mio padre non era l’unico che, venendo da “fuori”, aveva l’ambizione di sorprendere i bergamaschi con una cucina più saporita e variopinta della loro. Trovava appetitosi i casoncelli, così come la polenta domenicale che da sempre, in terra orobica, accompagna il coniglio ben rosolato in padella, ma all’ombra del Campanone ci si fermava lì.
Toscano era Enrico Panattoni, con il suo castagnaccio e il gelato alla stracciatella, pugliese era l’intraprendente Pino Capozzi dell’Agnello d’oro. Ognuno di loro avvertiva la gioiosa incombenza di diffondere il credo della propria tradizione culinaria: tra le vie della Bergamo medievale si respiravano gli effluvi di un sogno collettivo.
Il marketing prima del marketing.
I primi tempi dispensarono, con generosità, molte lacrime e sospiri di sconforto. Ai miei genitori, far amare la cucina del Sud, vincendo l’inscalfibile diffidenza orobica, sembrava un’impresa impossibile.
Grazie all’avvento della tivù, si incominciavano a scoprire altri mondi e altre culture, ma la pizza, come gli arancini o la parmigiana di melanzane, erano piatti ignoti alla maggior parte della gente, che all’epoca viaggiava di rado, se non mai.
Per papà, aprire quel locale in Città Alta era l’occasione della vita. Ma è nelle difficoltà che si aguzza l’ingegno, soprattutto se hai una mente fervida e brillante in cui dimora “il marketing prima del marketing”.
La sua prima iniziativa promozionale fu quella di recarsi al vicino Liceo Sarpi, durante l’intervallo, proponendo agli studenti i suoi tranci di pizza, profumati e appena usciti dal forno. La seconda, invece, fu quella di consentire ai giovani meridionali, da poco arrivati a Bergamo per un impiego statale, di avere una sorta di abbonamento, per il pranzo e la cena, da saldare il 27 di ogni mese, quando arrivava lo stipendio.
Perché non dici che sei napoletano? Cosa ti cambia? Devi dare alla gente quello che vuole la gente.
La pizza però, per quei pochi che sapevano cosa fosse, era un prodotto esclusivamente napoletano. A mio padre, pertanto, ponevano sempre la stessa domanda, il più delle volte in dialetto e con risposta annessa. “Fai la pizza? Allora sei di Napoli”.
Mio padre replicava con orgoglio di essere calabrese, reggino per la precisione, ma per i bergamaschi di allora, Calabria e Campania erano la stessa cosa. Stavano in Bassa Italia, dov’è la differenza? Per loro, Mimmo era uno scugnizzo napoletano, punto e basta.
Udendo per l’ennesima volta la stessa domanda rivolta a papà, mia mamma ebbe un’intuizione geniale nella sua semplicità: “Perché non dici che sei napoletano? Cosa ti cambia?”. Aggiungendo, da donna pratica qual era: “Devi dare alla gente quello che vuole la gente”.
All’inizio, a mio padre questa idea non piacque affatto. Gli sembrava di tradire la sua amata Calabria, ma alla fine dovette rassegnarsi: l’idea di mamma era quella giusta.
Le mezze misure lui non le aveva mai amate, perciò decise di investire fino in fondo sulla napoletanità di cui si era impossessato. Fece stampare l’immagine del Vesuvio sulla carta oleata con la quale serviva la pizza d’asporto, con una scritta inequivocabile: “Vera pizza napoletana”.
La poesia non è di chi la scrive, è di chi gli serve.
Un pizzaiolo calabrese a Bergamo. A ben guardare, mio padre anticipò i tempi. Oggi, la pizza napoletana è il prodotto più venduto al mondo e i pizzaioli non sono certo tutti di Posillipo o Fuorigrotta.
“L’arte tradizionale del pizzaiuolo napoletano” è stata riconosciuta dall’Unesco come parte del patrimonio culturale dell’umanità. Preparare alla perfezione l’impasto, eseguire quel tipico movimento rotatorio e cuocere nel forno a legna, necessitano di una certa abilità, ma ora ci sono pizzaioli bravissimi nati in Gambia o in Egitto, in Venezuela o a Hong Kong.
Anche adesso, che mio padre non c’è più, qualcuno mi chiede notizie delle sue origini napoletane. Ci sono delle volte in cui sto al gioco e annuisco, tenendo viva questa leggenda metropolitana.
Che poi, negli anni Cinquanta, Città Alta assomigliava davvero alla Napoli più umile e popolare. Non solo, la mia famiglia è calabrese d’origine e bergamasca d’adozione: se osservo la cartina dell’Italia, il capoluogo campano è proprio a metà strada.
Come disse Massimo Troisi, napoletano doc, ne “Il postino”, il suo ultimo film: “La poesia non è di chi la scrive, è di chi gli serve”. Credo valga anche per la pizza. Non è importante chi la fa, deve essere buona e rendere felice chi la mangia.
Se penso a mio padre e alla creatività, spontanea e genuina, con cui alimentava ogni iniziativa rivolta a promuovere la sua cucina, credo che nei manuali di economia, dove si legge che le quattro P del marketing sono Prodotto, Prezzo, Posizionamento e Promozione, si debba aggiungerne una quinta: la P di Poesia.