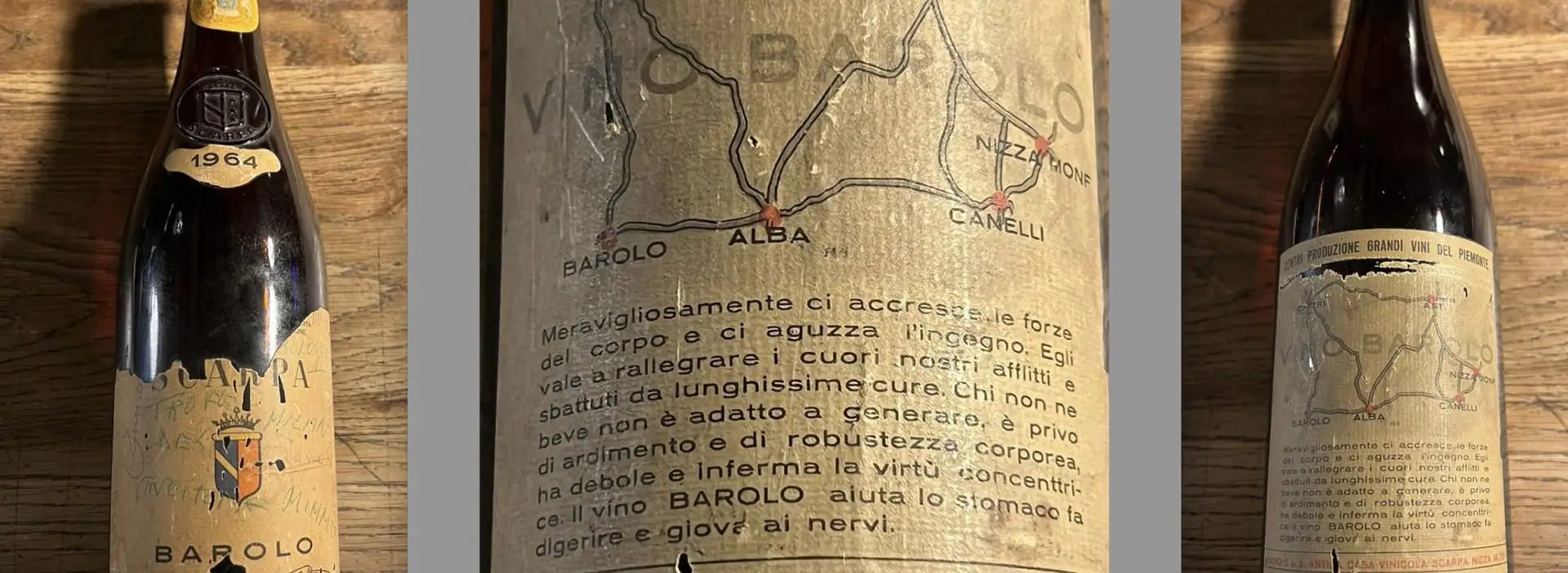- Le storie di Mimmo
Indiani e cowboy
Tempo di lettura: 6 minuti
“Papà, ma tu stavi con gli indiani o con i cowboy?”
Da piccolo, quando sentivo parlare di agguati e imboscate tra americani e tedeschi, mi immaginavo la Seconda Guerra Mondiale come quella che ritrovavo nei film di John Ford o nelle pagine dei fumetti di Tex Willer. Una lotta all’ultimo sangue tra indiani e cowboy.
Sapevo che papà aveva vissuto momenti terribili in quegli anni, ma lui non ne parlava volentieri. Se gli chiedevo qualcosa, lui glissava o si limitava a dire che, durante la Guerra, la gente sembrava impazzita, non capiva più niente nessuno. Era il suo modo per dirmi, riprendendo le conclusioni amare di Pavese, che ogni guerra è una guerra civile e fratricida.
Da ragazzo, ma anche in età adulta, mio padre considerava suo fratello maggiore Enzo un punto di riferimento a cui guardare. Un uomo dal cuore audace e generoso, che da partigiano visse nascosto nei fitti boschi che dall’alto scrutano guardinghi il lago di Como.
Enzo si diede alla macchia subito dopo aver sposato Pina, una bella ragazza milanese che oggi è ancora qui con noi e ha compiuto 104 anni. Non so bene come, ma Enzo e Pina si erano conosciuti in occasione di un evento sportivo, una maratona, disciplina nella quale mio zio eccelleva.
I due iniziarono a scriversi lunghe lettere appassionate fino a quando, con l’intenzione di poterla incontrare di nuovo, Enzo decise di arruolarsi. Fu così che lo mandarono al Nord, per la precisione a Parma, un distretto militare poco distante da Milano e dalla sua amata Pina.
L’illusione di aver messo le basi a una relazione più stabile durò poco. Qualche mese dopo, infatti, Enzo fu spedito al fronte, salpando proprio dal porto di Messina, lì dove era nato e cresciuto.
Sul molo, stretta alle altre madri di quei ragazzi pronti a morire per la patria, mia nonna sventolava un fazzoletto bianco già predisposto a raccogliere le sue lacrime. Trascorse poco più di una settimana e a casa sua giunsero i carabinieri con un telegramma di Enzo. Proveniva dall’ospedale militare di Taranto e riportava le seguenti sei parole: “Grazie a Santa Lucia sono salvo”.
Nella notte tra l’11 e il 12 novembre del 1940, la flotta della nostra Regia Marina venne bombardata nel porto di Taranto dagli aerei della Royal Navy britannica. Priva di radar e scarsa di contraerea, la base navale fu oggetto di un vero e proprio tiro a segno. Un colpo durissimo alla Marina italiana e al credito dei gerarchi in camicia nera.
Nonostante una profonda ferita a un braccio, Enzo si era salvato con la forza della disperazione, stringendo per ore le corde di una scialuppa nelle acque gelide del golfo. Quella stessa notte morirono 58 marinai italiani e oltre 600 rimasero feriti, senza contare le navi da guerra irrimediabilmente danneggiate.
Una volta guarito e rimessosi in forze, profondamente turbato da quell’esperienza, mio zio fu tra quegli italiani che si imposero di salvare il proprio Paese dall’orrore in cui il fascismo lo aveva trascinato. Abbracciati i valori della Resistenza, partì verso le vette lombarde portando con sé mio padre, quasi maggiorenne, che avrebbe dovuto arruolarsi da lì a poco.
Grazie al suo aspetto da ragazzino imberbe, e provvisto di un documento falso, mio padre andò a vivere con la zia Pina vicino a Bellagio, mentre Enzo se ne stava “sui monti a guerreggiar”.
Compito di papà era procurare il pane. Con la tessera in tasca andava a ritirarlo in un piccolo forno pigiato tra le case di un vicolo, stretto e in salita, nel centro storico del paese. “Belaas”, come lo chiamavano gli abitanti del luogo. Per raggiungerlo percorreva chilometri e chilometri lungo una strada male asfaltata e piena di buche. Ai piedi, delle scarpe di fortuna di due numeri più grandi.
Papà aveva modi gentili e sempre educati, tanto che la giovane fornaia, le rare volte in cui ne avanzava, gli regalava del pane secco. Quella michetta rafferma per lui era una vera delizia. Mettendo a dura prova la sua giovane dentatura, appena uscito dalla panetteria ogni volta la sgranocchiava con grande soddisfazione, manco fosse una pitta calabrese appena sfornata.
Sulla strada del ritorno, che curva dopo curva da Bellagio portava alla casa di Pina, in una fredda mattina di novembre incontrò un cane, forse più magro e affamato di lui. Bramando quel boccone prelibato che papà stringeva tra le mani, quella bestiola malandata e zoppicante iniziò a seguirlo.
Intento a rosicchiare con grande impegno quel pane duro come il travertino, papà avvertì l’insistenza di quello sguardo implorante. Si girò di scatto, notando quella bocca, ansimante e spalancata, irrigidita dalla fame di giorni. Ne fu turbato ma si impose di passare oltre. Perché mai avrebbe dovuto rinunciare a quella bontà che si era procurato facendo gli occhi dolci alla ragazza mora dietro al bancone? Fatto qualche passo, papà si girò nuovamente. Il cane era ancora lì e lo seguiva a debita distanza.
Fu allora che prese il pane, non lo spezzò perché era così duro che non si poteva dividere, e lo tirò a quel povero animale. Un gesto istintivo fatto con la certezza di pentirsene dopo pochi secondi.
In quegli anni bui, i buoni sentimenti e la necessità di sopravvivere erano in perenne conflitto. Quella volta non fu così. Del resto, se è vero che la guerra ci rende bestie, allora perché non ricominciare proprio da una bestia, un cane più affamato di un essere umano.
Di questo episodio papà non mi parlò mai. Troppo intimo per essere condiviso con altri, persino con i suoi figli. Me lo raccontò lo zio Enzo quando ero poco più che un bambino. Mi rivedo a osservarlo con gli occhi sgranati mentre lui sceglie con cautela le parole, accompagnandole da gesti ampi e teatrali, per mettere ancora più enfasi alla sua narrazione.
Volevo davvero bene a mio zio Enzo. Uomini come lui e mio padre avevano avuto il coraggio di rischiare la propria vita per cambiare le cose in un’Italia che aveva perso la bussola. Lo fecero con una buona dose di incoscienza donata dalla gioventù e dal timore di perdere quel tanto o poco che avevano, fosse un grande amore o un pezzo di pane.
Quella tra indiani e cowboy, invece, era tutt’altra faccenda. Una storia altrettanto tragica e ingiusta, dove un intero popolo fu annientato nell’indifferenza generale. Un dramma che si consumò tra canyon inospitali e praterie immense, dove la terra era grassa e fertile e, a ben vedere, ce ne sarebbe stata per tutti. Ma si sa, la storia la scrive chi vince, e i pellerossa diventarono quelli che massacravano i coloni, portandosi via i loro scalpi, e assaltavano le diligenze. Salvo poi riabilitarli quando ormai se ne contavano poche migliaia in tutto il Canada e gli Stati Uniti.
La presa di coscienza di questa cruda verità fu quanto mai dolorosa. Per fortuna potevo ancora contare sulla lealtà di Tex e i suoi “pards”, che non facevano alcuna differenza tra indiani e cowboy, ma solo tra buoni e cattivi.
Con un briciolo di immaginazione, Enzo e papà erano proprio come Tex Willer e Kit Carson. In difesa dei propri ideali, guardandosi le spalle l’un l’altro, non temevano di affrontare azzardi e pericoli. Erano uniti dal destino, e non solo perché erano fratelli.
Io che sin da piccolo osservo stupito le corrispondenze tra date e numeri, noto che Enzo nacque il 19 agosto, lo stesso giorno in cui mio padre ci ha lasciati per sempre. Enzo poi è mancato il 16 dicembre del 2000, tre giorni prima che nascesse il mio primo figlio. Pura casualità? Fatico a crederlo. Papà, cosa dici, questi numeri me li gioco al lotto?