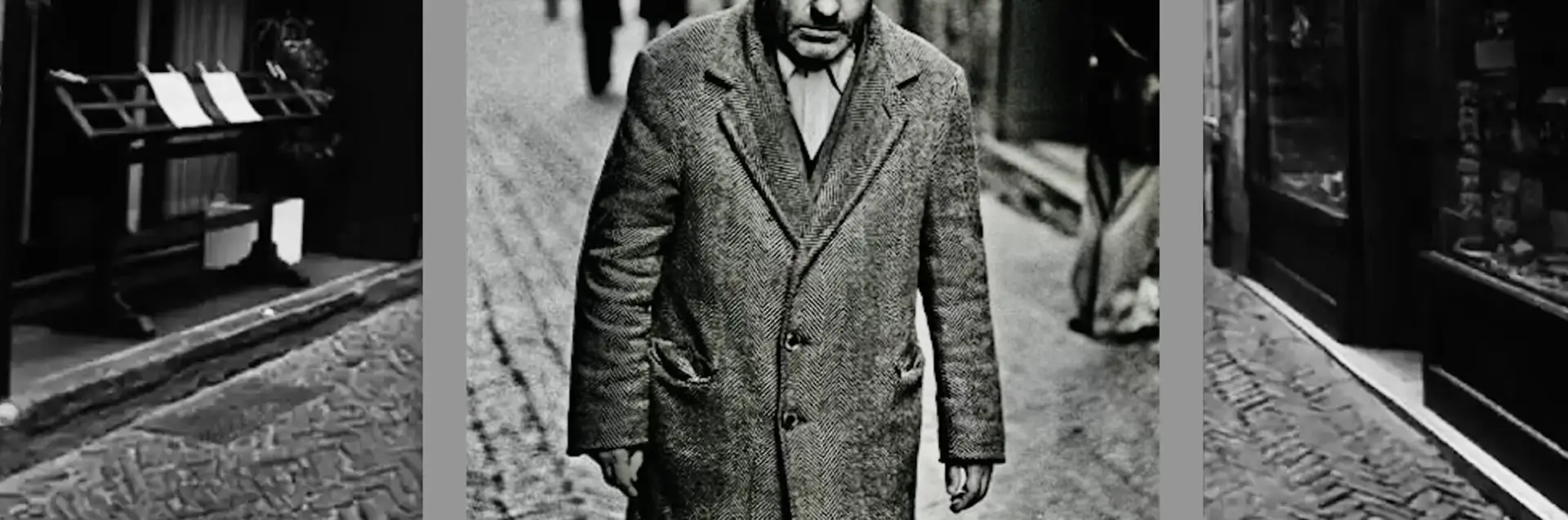- Nato in Città Alta
I ragazzi di Castagneta
Tempo di lettura: 5 minuti
Così fragili e così ingenui, tanto abili nell’andare in bicicletta su una ruota sola quanto inconsapevoli di essere i migliori.
A chi è cresciuto prendendo a calci un pallone per strada o in un cortile schiacciato tra i condomini, sbucciandosi le ginocchia sull’asfalto e infischiandosene di “prendere una storta”, il mondo contemporaneo appare incredibilmente accelerato. Fin troppo. Lo stesso vale per chi giocava a elastico o se ne stava ore sul divano di casa a consultare i Quindici.
Anche le distanze fisiche si sono ridotte parecchio. Adesso basta prendere un volo low cost e in un attimo sei a Berlino, a Londra o dove ti pare. E questo piace persino a noi boomer che non comprendiamo l’esistenza di TikTok e ci perdiamo in un bicchier d’acqua se dobbiamo impostare un sondaggio su WhatsApp.
Eppure, c’è stato un tempo, nemmeno così lontano, in cui le distanze tra un quartiere e un altro, tra la campagna e la città, tra borgo contadino e centro storico, sembravano enormi.
Era così anche per Città Alta e i colli che da sempre la cingono con rispetto e devozione. Può sembrare inverosimile, ma in due mondi così attigui e complementari sussistevano visioni della vita molto differenti.
Da una parte, un borgo popolato, attivo e vivace, ben protetto da quelle spesse Mura ereditate dalla Serenissima. Dall’altra, la silenziosa immobilità della terra, indissolubilmente legata a tempi e rituali che disciplinano ancora oggi il lavoro nei campi.
Uno di questi luoghi confinanti con Città Alta è Castagneta. Un nome che evoca l’abbondanza di castagni e dei loro preziosi frutti. Le gustose e provvidenziali castagne, per tanto tempo l’unico pane su cui potevano contare i poveri.
Acchiappavano al volo un maggiolino e salivano in scioltezza sugli alberi.
Me li ricordo bene i ragazzi e le ragazze di Castagneta, che alle medie arrivavano in bicicletta, percorrendo il tratto da casa a scuola in un susseguirsi di scatti improvvisi e impennate su una ruota sola.
Loro quella “distanza” la percepivano più marcata di altri. Si sentivano diversi, manifestando con un velo di pudore il desiderio di essere come noi, “cittadini” di Bergamo Alta.
Capaci di acchiappare al volo un maggiolino e salire in scioltezza sugli alberi, avevano doti atletiche fuori dal comune. Del resto, cos’è lo sport se non l’imitazione dei gesti primitivi legati alla sopravvivenza? Saltare, correre, scappare. In questo, i nostri coetanei di Castagneta erano più bravi di noi.
Ce lo dimostravano quotidianamente nel cortile della scuola, quando si giocava a pallone in attesa dell’inizio delle lezioni. Ogni mattina si formavano due squadre e io li ammiravo da bordo campo sperando che mi chiedessero di entrare, confidando che la campanella, per qualche insondabile motivo, ritardasse il suo acuto e indisponente trillare.
Adoravo il frastuono prodotto dalle scarpe di cuoio nel battere sul cemento del cortile. Così come quello della palla, il più delle volte sgonfia, che rimbalzava bofonchiando verso la porta. Gli eskimo e i giacconi a far da pali e la traversa immaginaria, che noi vedevamo benissimo.
Si voleva appartenere al “gruppo” per non sentirsi esclusi, ma allo stesso tempo mostrarsi diversi dagli altri, sprezzanti del rischio e di qualunque insidia.
Per tutti noi, che fossimo ragazzi di campagna o di città, figli entusiasti degli anni Sessanta, la modernità era andare altrove. Abitavi lungo la Corsarola o nei pressi di Piazza Vecchia? La meta era Città Bassa. Vivevi in una vecchia cascina posata sui colli? Non vedevi l’ora di varcare la soglia di una delle quattro porte che ancora oggi regolano l’accesso a Città Alta.
Volevamo dimostrare agli adulti di essere più aperti e progrediti di loro. Desiderosi di affrontare, senza alcun timore, quanto di bello o di brutto ci elargiva una realtà che mutava pelle rapidamente, forse troppo. Così, per sentirsi più emancipati e liberi dai dettami e dalle costrizioni, qualcuno scivolava in aree oscure e infide. Come l’uso delle droghe.
In quel persistente fluttuare tra il bisogno di distinguersi e quello di sentirsi parte di un gruppo, per un adolescente senza una cultura adeguata o privo di riferimenti certi, come una famiglia solida alle spalle, il mondo era disseminato di trappole.
Si voleva appartenere al “gruppo” per non sentirsi esclusi, ma allo stesso tempo mostrarsi diversi dagli altri, sprezzanti del rischio e di qualunque insidia. Non si comprendeva fino in fondo il pericolo di provare quelle porcherie e di rimanere intrappolati. Furono moltissimi i ragazzi e le ragazze di Castagneta che rimasero invischiati in queste dipendenze. Proprio loro, così ignari della propria forza e in fondo così indifesi.
Cattolici senza chiesa e socialisti senza partito.
Nel nostro Paese, ma non solo, il Novecento ha visto la migrazione dalla campagna alla città. Da un contesto contadino e cattolico, legato alle parrocchie e agli oratori, a una dimensione operaia che ha portato migliaia di uomini e donne a riversarsi nei grandi centri urbani, generando cattolici senza chiesa e socialisti senza partito.
Dai colli che fungevano da granaio per la città ai casolari disseminati tra i campi coltivati che andavano spopolandosi per essere trasformati in residenze riservate a pochi, ovviamente ricchi. Senza rendersene conto, si era passati da una vita assai misera, fatta di relazioni semplici e ruvide, a un’altra, forse appena migliore, ma comunque avara di certezze e carezze. Un disagio sociale che generò non pochi problemi, specie in quelle aree di confine, prossime alle città, come lo era Castagneta.
Ora i contadini rimasti sui colli si contano su una mano. Solo qualche decina di anni fa erano molti di più, ma a quel tempo la terra era tutto. Era cibo e fonte di reddito, tant’è vero che, da maggio a settembre, quelle case contadine sparse sui colli diventavano “frasche” dove rifocillarsi e acquistare i prodotti dell’orto o del frutteto di quegli agricoltori.
Ritornare alla terra.
Negli ultimi anni si avverte una lieve inversione di tendenza. Ci sono giovani che tornano alla terra, la amano e la coltivano con le giuste conoscenze, riprendendo quella strada che nella seconda metà del secolo scorso si era andata smarrendo.
Io lo vedo come un segno di fiducia e di speranza, una presa di coscienza delle nuove leve – una minima parte, lo so – che credono in un futuro più verde, umano e sostenibile.
Appena ne ho l’opportunità, mi inoltro in solitudine lungo i sentieri che si diramano sui nostri colli. Mi fa stare bene. Specie d’inverno, quando mi lascio avvolgere dalla foschia per isolarmi e riconnettermi a me stesso. In quei pochi momenti di pace assoluta, mi capita sovente di ripensare ai ragazzi di Castagneta che ho conosciuto, così fragili e così ingenui, tanto abili nell’andare in bicicletta su una ruota sola quanto inconsapevoli di essere i migliori.